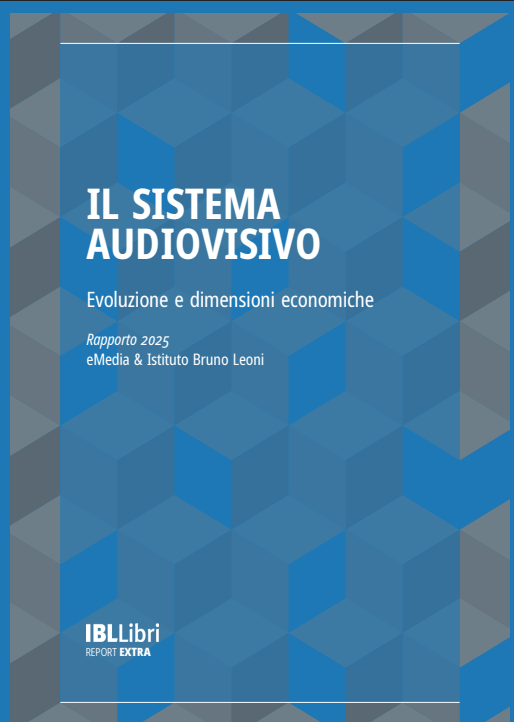Il sistema audiovisivo italiano tra squilibri strutturali e nuovi paradigmi
Evidenze dal Rapporto 2025 eMedia & Istituto Bruno Leoni
L'industria audiovisiva italiana, con un valore complessivo di circa 15 miliardi di euro nel 2023, rappresenta il 28% del sistema comunicazione-spettacolo e ben il 54% delle industrie culturali nazionali. Se includiamo anche la spesa in terminali e connessioni, il valore del settore raggiunge potenzialmente i 36 miliardi di euro. Nonostante questa centralità, il mercato audiovisivo italiano resta significativamente sottodimensionato rispetto ai principali competitor europei come Francia, Germania e Regno Unito, limitando così la competitività e la sostenibilità delle imprese editoriali locali.
Le Quattro Trasformazioni Fondamentali degli Ultimi Trent’anni
Il "Rapporto 2025 - Il Sistema Audiovisivo: Evoluzione e Dimensioni Economiche", a cura dell'Istituto Bruno Leoni ed eMedia, identifica quattro grandi trasformazioni che hanno rivoluzionato il settore:
Transizione dai supporti fisici al consumo online, dominato oggi da piattaforme di streaming globali come Netflix e Prime Video.
Insediamento diretto delle piattaforme globali sui mercati nazionali, che controllano interamente produzione, distribuzione e dati utente, erodendo quote significative del mercato domestico.
Emergere di modelli "post-editoriali", dove il valore economico si genera principalmente attraverso la profilazione degli utenti e il traffico online, a discapito della qualità editoriale tradizionale.
L’integrazione crescente dell’intelligenza artificiale, capace di superare barriere linguistiche e produttive, ampliando la pressione competitiva anche sui contenuti informativi e di intrattenimento.
Una dinamica particolarmente preoccupante è l’erosione delle risorse editoriali nazionali: la quota di pubblicità online destinata agli editori tradizionali è precipitata dal 29% del 2017 al 14,7% nel 2023, con l’85% delle risorse catturate da Google, Meta e YouTube. Questo fenomeno configura vere e proprie aree di fallimento di mercato, secondo quanto delineato dallo European Media Freedom Act (Regolamento UE 2024/1083), lasciando settori strategici come l’animazione in condizioni di dipendenza cronica da sostegni pubblici.
Nel periodo 2018-2023, il mercato audiovisivo nazionale ha registrato una crescita annuale composta (CAGR) del 3,6%, in linea con l'andamento generale del PIL. La resilienza del settore durante la pandemia è stata garantita dalla forte crescita delle offerte online, soprattutto servizi SVoD, che hanno compensato le perdite di sala e altri canali tradizionali.
In Italia, lo strumento del Tax Credit introdotto nel 2008 e potenziato dalla Legge Cinema 2016, finanziato con circa 700 milioni annui, ha sostenuto fortemente la produzione audiovisiva, coprendo nel 2023 il 32% dei costi produttivi. Nonostante il boom produttivo (402 film prodotti nel 2023), emergono criticità evidenti:
Quasi il 50% dei film beneficiari non ha raggiunto la distribuzione cinematografica.
La spesa reale ha superato di oltre 600 milioni di euro gli stanziamenti previsti tra il 2017 e il 2022.
Recenti riforme (Regolamento luglio 2024, Legge di Bilancio 2025) mirano a razionalizzare la spesa, introducendo requisiti più stringenti e tetti ai costi, ma generano tensioni significative tra piccoli produttori e policy maker.
Il Rapporto 2025 individua con chiarezza tre priorità strategiche per garantire un futuro sostenibile e competitivo al sistema audiovisivo italiano:
Ridefinire e stabilizzare gli strumenti di sostegno pubblico, bilanciando incentivi e sostenibilità economica, per tutelare la diversità culturale e assicurare efficacia produttiva.
Potenziare gli investimenti strutturali, rafforzando le imprese italiane sul mercato domestico e internazionale, per ridurre il gap dimensionale con i principali competitor europei.
Riposizionare l'editore/produttore come figura centrale nella catena del valore, garante della qualità, trasparenza e responsabilità editoriale, soprattutto nell’era delle piattaforme globali e dell'intelligenza artificiale.
Per approfondimento trovate il rapporto integrale qui
e il video della presentazione qui: